Il 26 aprile abbiamo assistito, sul palcoscenico del Teatro Regio di Torino, a una versione di Turandot discutibile da tanti punti di vista. Non ci si spiega come possa essere stata definita di grande successo giacché in quella serata in diversi hanno buttato la spugna dopo il primo atto. L’innovazione registica, anche quando è volutamente provocatoria, se poggia su solide basi
 Il 26 aprile abbiamo assistito, sul palcoscenico del Teatro Regio di Torino, a una versione di Turandot discutibile da tanti punti di vista. Non ci si spiega come possa essere stata definita di grande successo giacché in quella serata in diversi hanno buttato la spugna dopo il primo atto. L’innovazione registica, anche quando è volutamente provocatoria, se poggia su solide basi interpretative, è per noi fonte di ispirazione, stimolo, espressione di nuove possibilità. Certamente non è questo il caso. Stefano Poda, che abbiamo apprezzato in altri allestimenti, stavolta non ha saputo fermarsi davanti al precipizio, schiantandosi al suolo senza paracadute. Ha voluto seguire un’intuizione – Turandot non esiste offerta dalla dichiarazione delle tre maschere Ping, Pong e Pang che rende la Principessa di gelo una reazione di Calaf – senza curare, come richiesto, un’interpretazione così spinta e assoluta.
Il 26 aprile abbiamo assistito, sul palcoscenico del Teatro Regio di Torino, a una versione di Turandot discutibile da tanti punti di vista. Non ci si spiega come possa essere stata definita di grande successo giacché in quella serata in diversi hanno buttato la spugna dopo il primo atto. L’innovazione registica, anche quando è volutamente provocatoria, se poggia su solide basi interpretative, è per noi fonte di ispirazione, stimolo, espressione di nuove possibilità. Certamente non è questo il caso. Stefano Poda, che abbiamo apprezzato in altri allestimenti, stavolta non ha saputo fermarsi davanti al precipizio, schiantandosi al suolo senza paracadute. Ha voluto seguire un’intuizione – Turandot non esiste offerta dalla dichiarazione delle tre maschere Ping, Pong e Pang che rende la Principessa di gelo una reazione di Calaf – senza curare, come richiesto, un’interpretazione così spinta e assoluta.
Senza approfondire l’allestimento scenico, che avrebbe potuto essere foriero di un contesto metafisico, quanto ci ha stranito è la gestione dello spazio e talune scelte registiche a tratti inquietanti.
E abbiamo visto coreografie dove la sinuosità del corpo era la protagonista assoluta, coreografie che dal primo atto, quando ancora erano apprezzabili, si sono poi ridotte a ripetitivi schemi che come trappole occupavano la scena senza aggiungere nulla al contesto. E viene portato in scena un corpo scuoiato per rappresentare il sangue. Non si curano le relazioni tra i p ersonaggi. Si fa quasi morire dopo il primo atto Liù per mano di una freccia e la si vede camminare quando dovrebbe essere esanime in terra. Calaf è a terra strisciante prima di decidere di accettare la solenne sfida e poi si sdraia amenamente prima di rispondere ai tre quesiti che l’avrebbero portato alla morte qualora avesse errato a dare la risposta. Una Turandot mimata scenicamente da tante sue copie con una parrucca bionda con un caschetto che ricordava Raffaella Carrà degli anni Ottanta. Un’atmosfera da Star Wars che allontanava, respingeva l’occhio dello spettatore. Scon
ersonaggi. Si fa quasi morire dopo il primo atto Liù per mano di una freccia e la si vede camminare quando dovrebbe essere esanime in terra. Calaf è a terra strisciante prima di decidere di accettare la solenne sfida e poi si sdraia amenamente prima di rispondere ai tre quesiti che l’avrebbero portato alla morte qualora avesse errato a dare la risposta. Una Turandot mimata scenicamente da tante sue copie con una parrucca bionda con un caschetto che ricordava Raffaella Carrà degli anni Ottanta. Un’atmosfera da Star Wars che allontanava, respingeva l’occhio dello spettatore. Scon tato, in fine, il passaggio dei costumi dal bianco al nero.
tato, in fine, il passaggio dei costumi dal bianco al nero.
Abbiamo provato a trovare un senso, ma invano. Anche le luci sono state, ai nostri occhi, dissonanti. Addirittura l’inizio del terzo atto, quando il contesto è la notte della ricerca del nome dello straniero, è stato rappresentato come al massimo della luminosità. No sense! Reinterpretare sì, stravolgere il libretto senza considerare i fondamentali della regia no.
Avremmo potuto chiudere gli occhi, godendo della parte musicale, ma la direzione musicale di Jordi  Bernàcer è stata altrettanto deficiente: è stata, difatti, irregolare, precipitosa e disattenta ai bisogni dei cantanti che si sono trovati assolutamente abbandonati e che hanno fatto quel che hanno potuto. Non all’altezza del suo ruolo, ha proposto un primo atto al suon di tarantella: un ritmo rapido, concitato, dove il pathos pucciniano lasciava il posto alle goliardiche ballate delle feste irlandesi. L’Orchestra del Teatro Regio ha cercato di resistere per salvare il salvabile, anche se affrontare un mare in tempesta senza un valido nocchiere è realmente cosa ardua.
Bernàcer è stata altrettanto deficiente: è stata, difatti, irregolare, precipitosa e disattenta ai bisogni dei cantanti che si sono trovati assolutamente abbandonati e che hanno fatto quel che hanno potuto. Non all’altezza del suo ruolo, ha proposto un primo atto al suon di tarantella: un ritmo rapido, concitato, dove il pathos pucciniano lasciava il posto alle goliardiche ballate delle feste irlandesi. L’Orchestra del Teatro Regio ha cercato di resistere per salvare il salvabile, anche se affrontare un mare in tempesta senza un valido nocchiere è realmente cosa ardua.
Anche il reparto cantanti è stato deficitario perché non messo scenicamente (a volte si trovavano, soprattutto Calaf, a cantare di spalle o dal fondo del palcoscenico) e musicalmente nelle condizioni di potersi esprimer e al meglio. Ingela Brimberg non ha pienamente espresso il proprio potenziale: buoni sia tecnica sia il fraseggio, ma le sbavature non sono mancate al suo debutto sul palcoscenico del Regio nel ruolo così spinoso come quello di Turandot che non le vediamo propriamente cucito addosso. Dopo la visione della sua interpretazione e avendolo apprezzato in altri ruoli, ci si chiede se la vocalità brillante di Mikheil Sheshaberidz
e al meglio. Ingela Brimberg non ha pienamente espresso il proprio potenziale: buoni sia tecnica sia il fraseggio, ma le sbavature non sono mancate al suo debutto sul palcoscenico del Regio nel ruolo così spinoso come quello di Turandot che non le vediamo propriamente cucito addosso. Dopo la visione della sua interpretazione e avendolo apprezzato in altri ruoli, ci si chiede se la vocalità brillante di Mikheil Sheshaberidz e sia adatta al personaggio di Calaf che non è solo il Nessun dorma (non reso con la pienezza e il lungo sostegno dei grandi del passato), ma che presenta una complessità notevole. Inoltre superare la buca del Teatro Regio non è da tutti; difatti poco arrivava della sua voce. Giuliana Gianfaldoni, nonostante i limiti contestuali e non certo suoi, ha ben reso il personaggio di Liù: vocalità rotonda ricca di armonici, tecnica sicura e buon fraseggio sono state le leve per una interpretazione degna di apprezzamento. Ma l’indiscusso protagonista è stato Michele Pertusi che ha reso magistralmente il ruolo di Timur. Voce profonda e pastosa, potenza espressiva, tecnica eccellente e ottimo fraseggio lo
e sia adatta al personaggio di Calaf che non è solo il Nessun dorma (non reso con la pienezza e il lungo sostegno dei grandi del passato), ma che presenta una complessità notevole. Inoltre superare la buca del Teatro Regio non è da tutti; difatti poco arrivava della sua voce. Giuliana Gianfaldoni, nonostante i limiti contestuali e non certo suoi, ha ben reso il personaggio di Liù: vocalità rotonda ricca di armonici, tecnica sicura e buon fraseggio sono state le leve per una interpretazione degna di apprezzamento. Ma l’indiscusso protagonista è stato Michele Pertusi che ha reso magistralmente il ruolo di Timur. Voce profonda e pastosa, potenza espressiva, tecnica eccellente e ottimo fraseggio lo  rendono la vera luce di questo allestimento. Buona l’interpretazione di Nicola Pamio nei panni di Altoum, mentre veramente disarticolata e fuori tempo l’esecuzione delle tre maschere interpretate da Simone Del Savio (Ping), da Manuel Pierattelli (Pang) e da Alessandro Lanzi (Pong) di cui è difficile, per questo, poter fare altre considerazioni. Si tratta di un siparietto musicalmente e scenicamente complesso che negli anni ha richiesto a grandi professionisti di specializzarsi in questo, un’operetta nell’opera che merita studio e profonda attenzione, aspetti che non sono emersi nella recita di martedì 26 aprile. Regolare e pertinente Adolfo Corrado nel rendere un mandarino.
rendono la vera luce di questo allestimento. Buona l’interpretazione di Nicola Pamio nei panni di Altoum, mentre veramente disarticolata e fuori tempo l’esecuzione delle tre maschere interpretate da Simone Del Savio (Ping), da Manuel Pierattelli (Pang) e da Alessandro Lanzi (Pong) di cui è difficile, per questo, poter fare altre considerazioni. Si tratta di un siparietto musicalmente e scenicamente complesso che negli anni ha richiesto a grandi professionisti di specializzarsi in questo, un’operetta nell’opera che merita studio e profonda attenzione, aspetti che non sono emersi nella recita di martedì 26 aprile. Regolare e pertinente Adolfo Corrado nel rendere un mandarino.
Buona l’esecuzione del Coro e del Coro di voci bianche del Teatro Regio, istruiti rispettivamente da Andrea Secchi e Claudio Fenoglio, anche se, data la loro collocazione, non hanno potuto vibrare con forza e mostrare la propria tempra vocale.
Stasera, 5 maggio, l’ultima recita, alle ore 20.00.
Annunziato Gentiluomo
















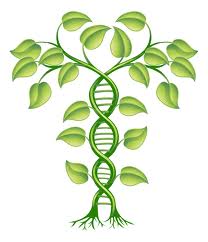





Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *