18 Marzo 1968, Università di Lawrence, Kansas. Un certo Robert “Bob” F. Kennedy, candidato democratico alle elezioni presidenziali americane, fratello del defunto presidente John, pronuncia un discorso sul PIL che, forse l’ultimo di tutta una vita, diventerà il testamento spirituale di tutto un popolo. È l’America degli anni ’60, una generazione di non violenti e
 18 Marzo 1968, Università di Lawrence, Kansas. Un certo Robert “Bob” F. Kennedy, candidato democratico alle elezioni presidenziali americane, fratello del defunto presidente John, pronuncia un discorso sul PIL che, forse l’ultimo di tutta una vita, diventerà il testamento spirituale di tutto un popolo. È l’America degli anni ’60, una generazione di non violenti e pacifisti, figli di JFK prima che di Woodstock. Un’America, piccola ma grande, che in nome della giustizia aveva adottato Martin Luther King e inneggiato alla fine del guerra ai Vietcong. Oggi, in troppo simili tempi di logorante crisi economica, sembra di risentirlo, il vecchio Bob, a sostenere la necessità di un nuovo equilibrio globale tra benessere economico, cultura, relazioni umane e rispetto per l’ambiente: quell’equilibrio che il PIL, ideato nel 1934 dal premio Nobel Kuznets come termometro economico post-crisi del ‘29, non può garantire, e che il FIL (acronimo per Felicità Interna Lorda) , parallelo ironico e provocatorio del Prodotto Interno Lordo, si propone di raggiungere.
18 Marzo 1968, Università di Lawrence, Kansas. Un certo Robert “Bob” F. Kennedy, candidato democratico alle elezioni presidenziali americane, fratello del defunto presidente John, pronuncia un discorso sul PIL che, forse l’ultimo di tutta una vita, diventerà il testamento spirituale di tutto un popolo. È l’America degli anni ’60, una generazione di non violenti e pacifisti, figli di JFK prima che di Woodstock. Un’America, piccola ma grande, che in nome della giustizia aveva adottato Martin Luther King e inneggiato alla fine del guerra ai Vietcong. Oggi, in troppo simili tempi di logorante crisi economica, sembra di risentirlo, il vecchio Bob, a sostenere la necessità di un nuovo equilibrio globale tra benessere economico, cultura, relazioni umane e rispetto per l’ambiente: quell’equilibrio che il PIL, ideato nel 1934 dal premio Nobel Kuznets come termometro economico post-crisi del ‘29, non può garantire, e che il FIL (acronimo per Felicità Interna Lorda) , parallelo ironico e provocatorio del Prodotto Interno Lordo, si propone di raggiungere.
Già allora Bobby, che tre mesi dopo sarebbe stato assassinato dal proiettile di un revolver a Los Angeles, impostava il suo discorso su una denuncia, quella dell’inadeguatezza del PIL come indicatore del benessere delle nazioni: «misura tutto – dice – eccetto quello che rende la vita degna di essere vissuta. Ci dice tutto sull’America, eccetto il motivo per cui siamo orgogliosi di essere americani».
 Qualche tempo dopo, era il 1974, Richard Easterlin, professore di economia all’Università della California meridionale, definiva il suo celebre paradosso della felicità. Proprio allora, col paradosso di Easterlin, che evidenziava come nel corso della vita la felicità delle persone dipende molto poco dalle variazioni di reddito e di ricchezza, gli economisti videro sgretolarsi di fronte ai loro occhi la base secolare di ogni convinzione, quella cioè del reddito come fonte totale di benessere, e quindi di felicità. Studi recenti dimostrerebbero invece che il PIL, così come oggi viene calcolato, cioè come valore monetario totale dei beni e servizi prodotti, non sarebbe neppure un buon indicatore di benessere economico.
Qualche tempo dopo, era il 1974, Richard Easterlin, professore di economia all’Università della California meridionale, definiva il suo celebre paradosso della felicità. Proprio allora, col paradosso di Easterlin, che evidenziava come nel corso della vita la felicità delle persone dipende molto poco dalle variazioni di reddito e di ricchezza, gli economisti videro sgretolarsi di fronte ai loro occhi la base secolare di ogni convinzione, quella cioè del reddito come fonte totale di benessere, e quindi di felicità. Studi recenti dimostrerebbero invece che il PIL, così come oggi viene calcolato, cioè come valore monetario totale dei beni e servizi prodotti, non sarebbe neppure un buon indicatore di benessere economico.
 Fortunatamente le alternative non mancano. Se infatti il Canada ha sostituito al famigerato PIL il Canadian Institute of Well Being; se Sarkozy in tempi non sospetti nominava una commissione ad hoc, presieduta da Joseph Stiglitz, volta a riformarlo, la risposta più originale viene però dall’alto. Beninteso, nulla di trascendente. Si tratta semplicemente di un piccolo stato montuoso sull’altopiano dell’Himalaya, il Bhutan, che ormai da più di quattro anni adopera il FIL per calcolare il benessere della popolazione. Calcolato nei venti distretti che lo costituiscono e ormai parte della costituzione (all’art. 9), nel 2010 ha stimato la felicità a 0,743 in una
Fortunatamente le alternative non mancano. Se infatti il Canada ha sostituito al famigerato PIL il Canadian Institute of Well Being; se Sarkozy in tempi non sospetti nominava una commissione ad hoc, presieduta da Joseph Stiglitz, volta a riformarlo, la risposta più originale viene però dall’alto. Beninteso, nulla di trascendente. Si tratta semplicemente di un piccolo stato montuoso sull’altopiano dell’Himalaya, il Bhutan, che ormai da più di quattro anni adopera il FIL per calcolare il benessere della popolazione. Calcolato nei venti distretti che lo costituiscono e ormai parte della costituzione (all’art. 9), nel 2010 ha stimato la felicità a 0,743 in una  scala da 0 a 1, dimostrando come il benessere reale dei cittadini, anche in un piccolo paese, può essere tra i migliori al mondo.
scala da 0 a 1, dimostrando come il benessere reale dei cittadini, anche in un piccolo paese, può essere tra i migliori al mondo.
Il FIL, in sintesi, tenta di proporsi come indicatore altro rispetto al PIL, come regolatore della qualità standard di vita. L’obiettivo però non è una regressione, una retrocessione. Non si vuole passare per anti-tecnologici o anti-materialisti, tutt’altro. E la scientificità che ne sta alla base lo testimonia. Pur non mirando a quantificare la felicità, infatti, il FIL poggia su quattro pilastri completamente ignorati dal PIL: sviluppo economico equo e sostenibile, conservazione ambientale, cultura e buon governo. È un po’ come se la felicità, misura di solito legata al singolo individuo, venisse ricercata insieme e scientificamente. Ma non è un attimo, un soffio: è il frutto di una scelta lungimirante fatta pensando alla comunità e al futuro. Dunque, convinto che lo sviluppo debba promuovere la felicità collettiva, il FIL non sostituisce il PIL, lo completa.
 Nella vita come in economia dunque, la felicità non è semplice da raggiungere. Lo è perché il benessere economico comporta un adattamento edonico (cioè un miglioramento momentaneo che porta poi all’assuefazione). Lo è perché la soddisfazione economica dipende anche dal confronto con gli altri, per il cosiddetto effetto tapis roulant. Infine, lo è a causa della crisi della vita relazionale.
Nella vita come in economia dunque, la felicità non è semplice da raggiungere. Lo è perché il benessere economico comporta un adattamento edonico (cioè un miglioramento momentaneo che porta poi all’assuefazione). Lo è perché la soddisfazione economica dipende anche dal confronto con gli altri, per il cosiddetto effetto tapis roulant. Infine, lo è a causa della crisi della vita relazionale.
Il fenomeno FIL però non si esaurisce nel Bhutan. Una conferenza sul FIL si tenne infatti nel 2005 in Nuova Scozia (Canada), con grande successo di pubblico, in particolare buddhista. In Italia invece, a promuoverlo è il FILFEST (Festival della Felicità Interna Lorda), un’immersione di tre giorni nell’universo eudaimonistico (quest’anno a 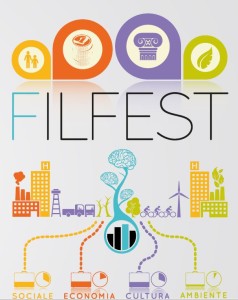 Catania, 4-6 dicembre) di chi ritiene che l’economia e lo sviluppo debbano concorrere al benessere umano e al perseguimento di fini collettivi. È la grande sfida di chi all’ISTAT e ai suoi indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) risponde con una riflessione che, oltre a chiedersi cosa ci renda più felici o infelici, si propone di collegare le quattro dimensioni della crisi (economica, ambientale, soddisfazione personale, vita relazionale) che il PIL manca di analizzare in toto. E a chi obietta che il mercato è nelle mani delle multinazionali, monopolio delle grande industrie, risponde che loro, la domanda, sono una parte del mercato, la parte più importante: perché il voto col portafoglio è più forte del voto politico.
Catania, 4-6 dicembre) di chi ritiene che l’economia e lo sviluppo debbano concorrere al benessere umano e al perseguimento di fini collettivi. È la grande sfida di chi all’ISTAT e ai suoi indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) risponde con una riflessione che, oltre a chiedersi cosa ci renda più felici o infelici, si propone di collegare le quattro dimensioni della crisi (economica, ambientale, soddisfazione personale, vita relazionale) che il PIL manca di analizzare in toto. E a chi obietta che il mercato è nelle mani delle multinazionali, monopolio delle grande industrie, risponde che loro, la domanda, sono una parte del mercato, la parte più importante: perché il voto col portafoglio è più forte del voto politico.
Quest’anno dedicato alle Città Felici, il Festival si riconnetterà alla tradizione tutta italiana delle città-stato medievali, luoghi, prima che di mercato, di civilizzazione. Il tutto aperto alla condivisione di visioni, utopie, che stimolino l’immaginario collettivo a nutrire nuove  possibilità d’azione sullo spazio urbano. Perché entrare nell’inferno dei viventi – l’unico davvero esistente secondo Italo Calvino – non significa necessariamente soffrire, ma è un modo per imparare a conoscere «chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e dargli spazio».
possibilità d’azione sullo spazio urbano. Perché entrare nell’inferno dei viventi – l’unico davvero esistente secondo Italo Calvino – non significa necessariamente soffrire, ma è un modo per imparare a conoscere «chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e dargli spazio».
La felicità, insomma, è un paradosso. Proprio il paradosso per cui Easterlin suggeriva di destinare il tempo a quei domini in cui adattamento edonico e confronto sociale sono meno importanti, ad esempio nei beni relazionali. Il che poi è come dire che per essere felici bisogna essere in due. Almeno.
Giuseppe Parasporo
[Fonti immagini: lifegate.it, pavikuqyl.luservice.com, schoolstorming.wordpress.com, bhutantour.it, merriam-webster.com, telegraph.co.uk, filfest.org, facebook.com/FestivalFelicitaInternaLorda]
















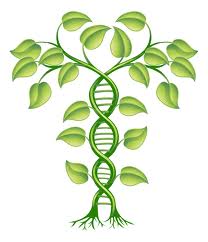






Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *